Nel vento della sera
Questo libro avrebbe dovuto essere, nelle mie iniziali intenzioni, solo una raccolta di poesie scritte nel corso del 2015. È divenuto invece pian piano – e la cosa mi ha molto intrigato – una simbiosi di parole e immagini; dove le immagini vorrebbero essere sug- gestive dei versi, e i frammenti di vecchie mie poesie – posti come didascalie – il corolla- rio delle immagini e dei versi. Una sorta di ambizioso capriccio letterario, un tentativo di sintesi espressiva e comunicativa (al di là del valore delle poesie), il cui risultato lascio giudicare ai miei quattro lettori.
Le poesie nascono quasi tutte come sentimenti del sogno. Alcune sono criptiche, a tratti alogiche, ma è il sogno quasi sempre alogico, tanto da essere oggetto di molteplici in- terpretazioni psicoanalitiche. La poesia, ad esempio, che apre la raccolta, nel vento della sera, è una tiritera che mi sono ritrovato a canticchiare nel sonno, che ho continuato a canticchiare nel dormiveglia, e che, svegliatomi all’improvviso, ho appuntato su carta prima di riaddormentarmi.
Al lettore, e alla sua personale sensibilità, affido l’interpretazione dei versi.
l’autore
Prefazione
Una simbiosi di parole, luci, immagini, colori e ricordi in un’atmosfera onirica, ecco cos’è l’ultima raccolta poetica di Luciano De Angelis. Negli anni dell’anzianità ritornano alla mente del poeta i temi ricorrenti della sua vita, che egli ricorda nella ripetitività dell’esistenza e riaffermano la noia, l’inutilità, il dibattersi invano contro le ingiustizie del mondo. La vita umana non è quindi che una “oscura tiritera” di parole incomplete, “mozze”, mentre un “cane nero” non riesce ad abbaiare, ma “singulta” e si rode dal di dentro, anche lui incapace di comunicare la sua rabbia (p.15). Perfino la scelta dei caratteri tipografici in minuscolo sottolinea la tendenza dell’autore ad indicare un approccio minimalistico, un messaggio sussurra- to diretto allo spirito, dove non si può più affermare niente con sicurezza, la voce si spegne pian piano in una dimensione a cui si è ormai estranei e anche la vita stessa del poeta è in minuscolo.
Nei paesi anglosassoni si dice “Mi sento blu”, quando si vuole indicare che si è tristi o depressi. E qui il blu è il colore che spesso ritorna a sfondo di immagini e di parole (p. 17). L’albeggiare, altrove visione rosea e positiva della vita, diventa “livido” come il volto di un malato, con neri presagi di cirri scuri che incombono sui pericoli e gli inganni del mondo, simboleg- giati dai crepacci nascosti dalla neve. Il messaggio di questa poesia, ideata in una struttura circolare concentrica, riconduce, soprattutto nella stanza centrale, a motivi leopardiani, specialmente nella scelta lessicale che parla di illusioni e di un “naufragare/immemore/nel deliquio blu dei sensi” re- miniscente del “naufragar… in questo mare”. Si tratta di un parallelismo più che evidente: in entrambi i casi il naufragare indica un perdersi per non ritrovarsi più in un’essenza (mare o sensi che siano) la cui immensità si smarrisce nell’ineffabile.
La concezione del tempo che passa inesorabilmente si riconosce in “l’enig- ma”, lirica graficamente a forma di clessidra, dove i granelli di sabbia che vi scendono spietati rallentano alla strozzatura centrale, con la domanda tutta in maiuscolo: “CHI SEI?” Per il poeta la vita è un enigma insolubile e la crisi esistenziale è nel nucleo di ognuno di noi. Nella notte, nostra e dei tempi, appaiono mitici mostri che ci assalgono nel momento onirico dell’abbandono, quando siamo indifesi di fronte a serpi maligne, draghi rapaci e ingannevoli mutanti (p. 23). La ragione vi si oppone, ma le memorie di una vita non le sono sufficienti e si deve arrendere. Echi montaliani di un paesaggio arido e salino ritornano con allitterazioni forzate in un’al- ternanza di labiodentali sorde e sonore (“fruscio vago di foglie lontane/ che vorticano”) e sottolineano il parallelismo tra il mezzogiorno del poeta ligure con la mezzanotte dell’autore abruzzese. Anche De Angelis non vive più pienamente, ma sopravvive, forse come lo stesso Montale, “al cinque per cento”, dibattendosi nella solitudine di un mondo che non ammette diversità, ma accetta solamente un “Pensiero unico” che ci imbriglia in un monismo etico retrogrado e ingiusto (p. 30).
Allora l’autore si rivolge a se stesso in un ultimo tentativo di conoscersi e si guarda le mani in una sineddoche emblematica di tutto il suo essere (p. 25). Si chiede se la realtà che lo circonda sia materia o antimateria, se la sua per- sonalità si sia sdoppiata. Non capisce chi sia il suo “gemello crudele/il sosia perturbante che mi perseguita/nell’inconscio” della notte, o se si identifica in un Dr. Jekyll e un Mr. Hyde estranei l’uno all’altro. Sin dalle prime pagine della silloge l’idea di uno sdoppiamento accoppia parallelamente parole ed immagini in assurdi ossimori letterali e visivi: i due profili che contrappon- gono la notte all’alba (p. 40); l’immagine speculare del poeta – stagliata sul nero di uno sfondo senza speranza – con l’indice puntato contro se stesso in una domanda o un’accusa (pag. 24); i due corpi danzanti, uno irradiato di luce e l’altro nell’ombra della malvagità, su di un contrasto di colori accesi (p. 37). La ricerca esistenziale è indomita con “i piedi saldamente piantati/ sul nulla”, ed è rappresentata dai numerosi altri ossimori che rispecchiano l’animo del poeta (“vivi morenti”, “triste Pasqua”, “primavera autunnale”) perché così è anche la vita.
La lotta interna, la crisi d’identità, la ricerca di se stesso o di un varco che gli permetta una fuga sono sempre presenti nella mente del poeta che, novello Alice in un paese senza più meraviglie, si dibatte in un universo ormai estraneo e malvagio. Il pessimismo raggiunge nuove vette, in una leopardiana ascesi, fino a diventare non solo individuale o storico, ma universale nella sua totalità. Lo sconforto lo coglie nel paragone tra l’egoistica società odierna che rigetta i propri fratelli profughi in cerca di aiuto e la memoria di un bambino che, durante la seconda guerra mondiale, “fuggiva dalle bombe/e/ dalla guerra/alla ricerca di un rifugio/che/i poverissimi di allora non gli negarono/mai” (p. 29).
Allora sorge la rabbia in un enfatico “no!”, perché lo spirito del nostro non si arrende nemmeno dopo l’insorgere degli anni, in un flusso di pensiero bat- tagliero come sempre, come nella sua giovinezza. L’anelito, pur irrealizzabile, a librarsi nella libertà dell’aria e senza il peso della realtà presente arriva allora prorompente, come per il rondone, “creatura d’aria”, che finalmente può tornare libero e felice, senza la gravità del passato, dei rimorsi per il tempo perduto, della memoria.
Dopo echi montaliani e leopardiani troviamo anche una reminiscenza ata- vica legata alla terra del poeta. I versi e le parole scandiscono il ritmo delle gocce di pioggia di dannunziana memoria, mentre un passato doloroso, riscoperto nel ricordo, gli rammenta che ormai sono finite tutte le sue illu- sioni e speranze, e che “il vero dramma/per me/non è perdere la memoria/ ma/ ritrovarla” (p. 39). Nella dimensione onirica gli tornano le immagini del passato, oramai solo fantasma della donna amata che, da novello Enea, egli cerca di abbracciare ma gli svanisce tra le braccia: “ho cercato di ab- bracciarti/per consolarti” (p.45). L’antico ritratto del 1954 (p. 44) aveva già il pallore fatale in un volto impenetrabile e marmoreo, illuminato dalla luce fredda della morte, e al poeta rimane solamente l’attesa della fine. For- se quella è il varco tanto atteso, perché “sento/che ora sono pronto” (p. 43).
Altre e più forti reminiscenze ataviche riaffiorano nell’ultima lirica, dedi- cata all’“elogio di una penna stilografica” esposta a Milano all’Expo 2015 (p.49). E non a caso qui, con l’immagine della pietra “così bianca/così dura”, ci tornano alla mente i versi di “Sono una creatura” del poeta più amato, Giuseppe Ungaretti. Si tratta di una penna in roccia della Majella, la montagna madre degli abruzzesi, sulla quale si racconta che la mitica Pleiade Maja avesse portato il figlio ferito in guerra per curarlo con il fiore medicamentoso del maggiociondolo, un albero che fiorisce nel mese di maggio. Ma la dea vi era arrivata troppo presto, il figlio morì, lei si accasciò su se stessa per il dolore e divenne montagna madre. Si dice che tuttora si lamenti per la morte del figlio e che, soprattutto d’inverno, la si senta an- cora piangere accompagnata dal rumore del vento che urla tra le sue caver- ne, le rocce e gli alberi. Questa penna è fatta di terra madre, di un dolore che non cessa mai, ma ci accoglie, rimane, ci dà quella continuità e calore che non potremmo trovare altrove. La sua pietra è dura, ma anche sicura, dolce e accogliente per chi la ama e si riconosce in essa. Forse in questo il poeta trova finalmente la sua identità, nel mito antico della sua terra, nelle radici degli alberi che crescono sul pendio della montagna. Forse questo è finalmente il “varco” tanto cercato che gli permette anche di scrivere le sue parole, nell’immagine simbolica di una penna che fissa i suoi segni nell’eterno dell’inchiostro, per se stesso, ma anche e soprattutto per quelli che verranno.
Cinzia Donatelli Noble
Brigham Young University




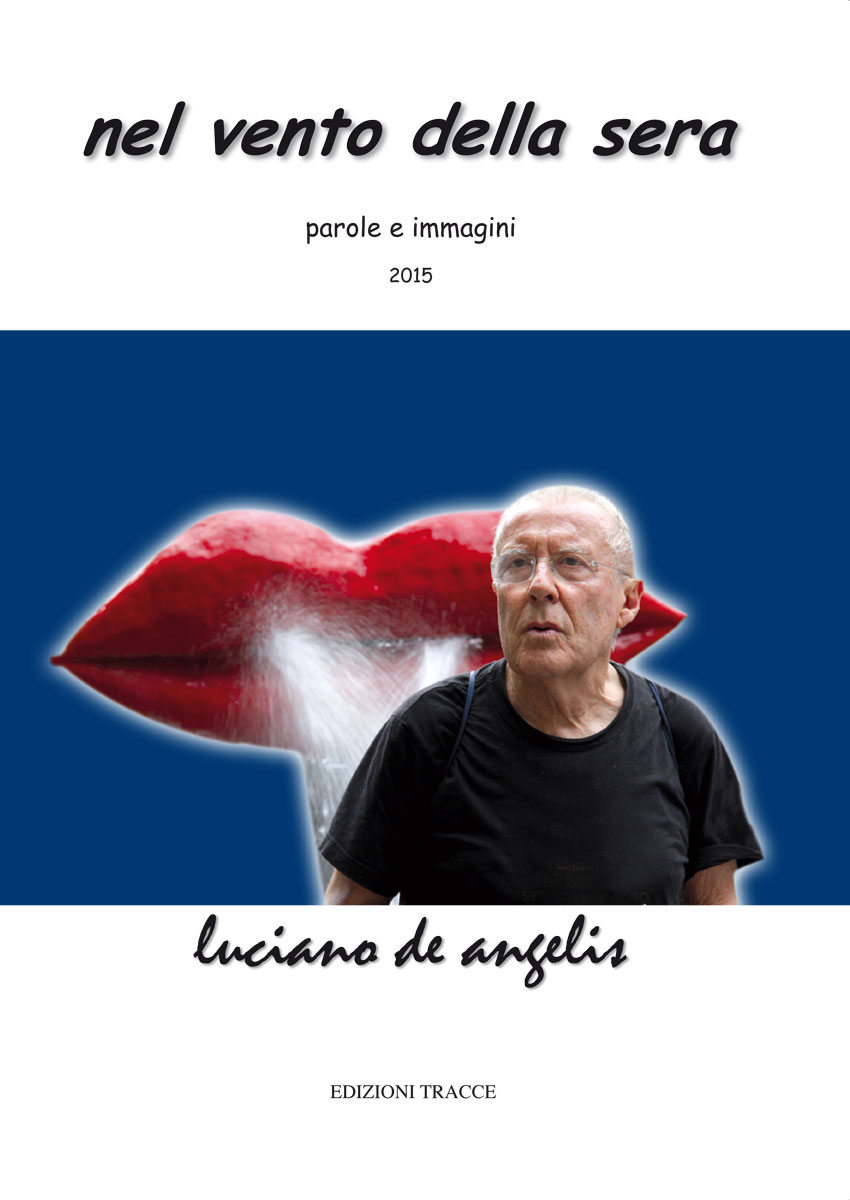
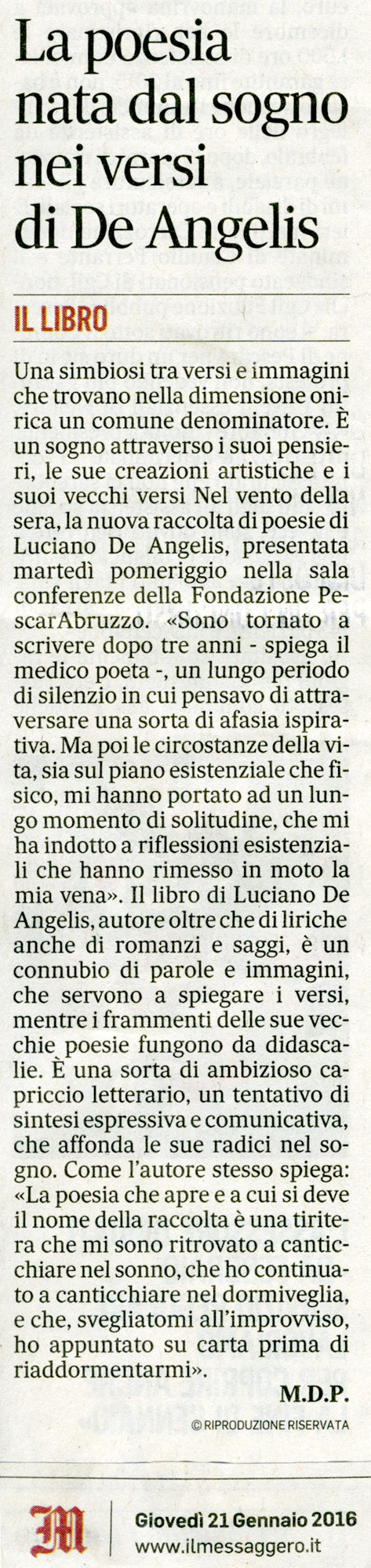
Lascia un commento